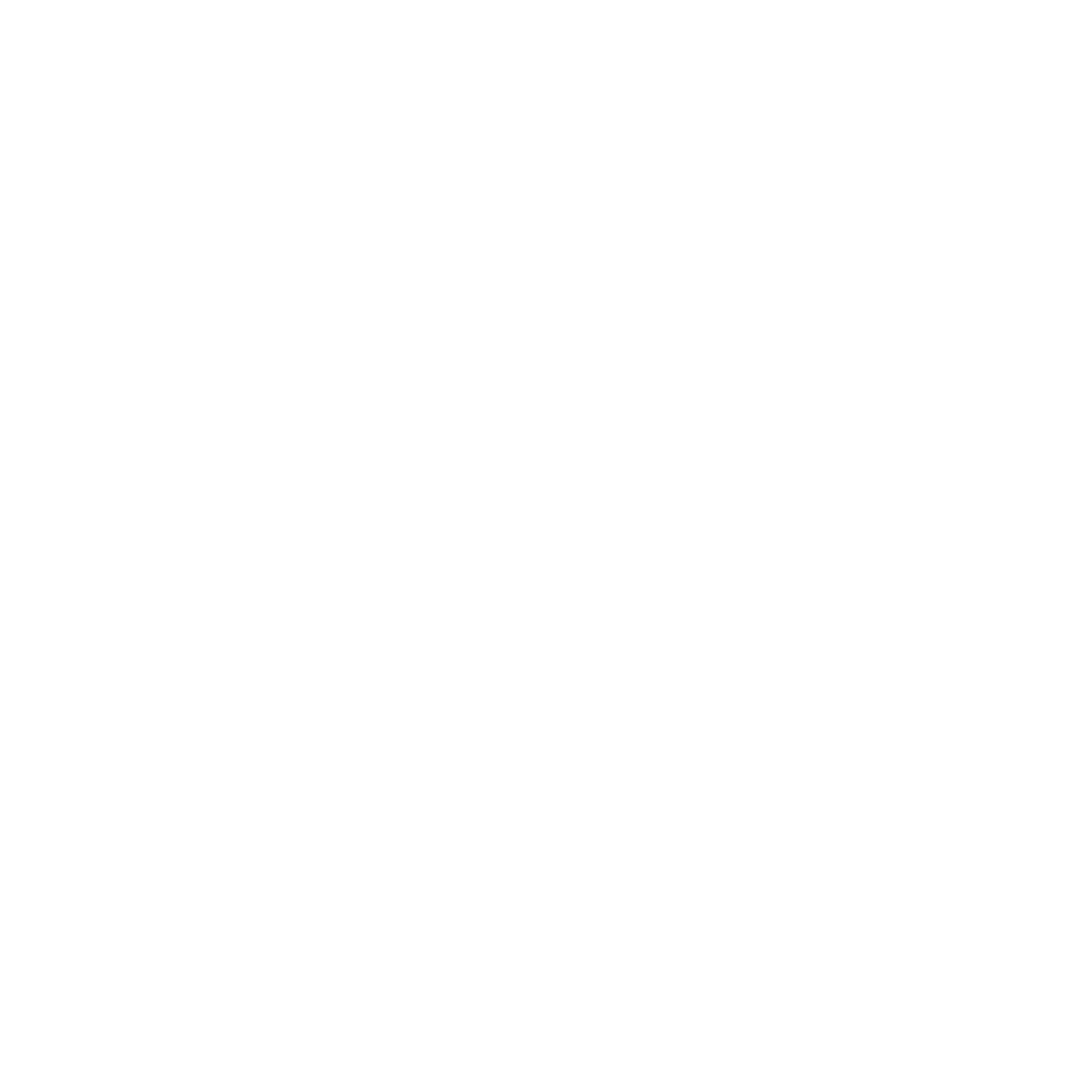La tutela degli archivi in ambito nazionale
All'indomani dell'Unità d'Italia, dopo approfondito e vivace dibattito culturale e politico prevalse il partito di coloro che, pur riconoscendone il valore storico culturale, vedevano nella gestione degli archivi il prevalente interesse dello Stato alla tutela della certezza del diritto e della riservatezza.
Queste esigenze di controllo sulla memoria storica, e allo stesso tempo di controllo burocratico, connotarono le scelte accentratrici del legislatore postunitario tra il 1874 e il 1875 (regi decreti 5 mar. 1874, n. 1852, 26 mar. 1874, n. 1861, 27 mag. 1875, n. 2552). Con questi provvedimenti furono creati e regolamentati 17 Archivi di Stato, che coincidevano di massima con istituti archivistici di concentrazione già presenti nelle capitali degli stati preunitari; erano posti alle dipendenze del Ministero dell'interno ed erano deputati alla conservazione della memoria storica di quegli stati. L'attenzione primaria era quindi rivolta alla documentazione statale.
Tuttavia, anche la documentazione che si trovava al di fuori degli Archivi di Stato fu oggetto di attenzione da parte del legislatore. Con il r.d. 31 mag. 1874, n. 1949 furono create 10 Sovrintendenze (denominate "Sovrintendenze agli archivi di Stato") secondo le antiche circoscrizioni storiche: agli archivi piemontesi, liguri, lombardi, veneti, emiliani, toscani, romani (per Lazio, Umbria, Marche), napoletani (per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), siciliani e sardi.
Queste Sovrintendenze avevano compiti di vigilanza da un lato sugli Archivi di Stato, che quindi erano loro subordinati sia in materia tecnico-archivistica sia di personale, dall'altro lato sulla documentazione di interesse storico e amministrativo che si trovava al di fuori degli Archivi di Stato (in particolare sugli archivi delle province, comuni, corpi morali, curie diocesane ed altri enti ecclesiastici). Queste Sovrintendenze ebbero però vita breve e furono soppresse dal 1892 (r.d. 31 dic. 1891, n. 745), affidando i compiti di vigilanza alle stesse direzioni degli Archivi di Stato.
Per quanto riguarda gli archivi privati (familiari e personali), il legislatore del 1875 – in sintonia con la cultura liberistica del nuovo stato unitario – preferì non intervenire con disposizioni limitative della proprietà.
La prima legge organica in materia di vigilanza statale sugli archivi sia privati sia degli enti pubblici è quella del 1939 (l. 22 dic. 1939, n. 2006), che si inscrive nel corpus di leggi emanate nello stesso periodo dal regime fascista sulle "cose di interesse storico e artistico", oggi ricomprese sotto il concetto più ampio di "beni culturali". La legge del '39 riordinava gli Archivi di Stato e ridefiniva le funzioni di vigilanza sugli archivi degli enti pubblici non statali e sugli archivi privati; analogamente a quanto veniva disposto per i beni storico-artistici, le maggiori novità riguardavano soprattutto gli archivi privati: una volta accertato che un archivio privato rivestiva particolare interesse storico, il soprintendente archivistico competente per territorio era tenuto a emanare un atto amministrativo di carattere vincolistico (atto di notifica), da cui discendeva una serie di limitazioni per il proprietario.
A partire dal 1939, dunque, gli archivi privati venivano sottoposti a tutela al pari degli archivi pubblici, e per attuare una efficace vigilanza sul patrimonio archivistico non statale venivano reintrodotte le Soprintendenze archivistiche, in numero di 9 e quindi con competenze territoriali assai ampie (Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo), tali da risultare con il passare del tempo inadeguate.
I principi introdotti nel 1939 furono confermati e ampliati dalla legge archivistica del 1963 (d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409) che istituì 18 Soprintendenze archivistiche, una per regione (poi aumentate a 19 con la creazione della regione Molise).
Tra gli anni '60 e '70 un ampio movimento, tendente all'elaborazione di una nozione unitaria di "bene culturale", fondata su un concetto antropologico di cultura, preludeva a un nuovo modo di concepire la gestione del patrimonio culturale. L'attenzione si spostava dal valore culturale rappresentato dall'oggetto materiale alla funzione sociale del bene culturale, visto come fattore di sviluppo intellettuale della collettività; i tempi erano favorevoli alla creazione di un'amministrazione specifica per la salvaguardia del patrimonio culturale italiano.
Tra il 1974 e il 1975 fu istituito il Ministero per i beni culturali e ambientali (d.l. 14 dic. 1974, n. 657 convertito in l. 29 gen. 1975, n. 5) in cui confluirono le due direzioni generali, da un lato delle biblioteche e accademie, dall'altro delle antichità e belle arti, provenienti dal Ministero della pubblica istruzione, come pure l'amministrazione archivistica proveniente dal Ministero dell'interno. Per quanto riguarda gli archivi era fatta salva, in capo al Ministero dell'interno, la competenza in materia di autorizzazione alla consultazione dei documenti riservati (d.p.r. 30 dic. 1975, n. 854). All'interno del nuovo ministero le Soprintendenze archivistiche mantenevano le proprie funzioni di vigilanza sugli archivi non statali.
Le novità interpretative introdotte dal legislatore del 1975 hanno trovato conferma e più completa formulazione dapprima nel 1998 con la riforma del Ministero, che diventò Ministero per i beni e le attività culturali (d.lgs. 20 ott. 1998, n. 368), e successivamente con il generale processo di trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, confermato dalla riforma del titolo V della Costituzione (l.cost. 18 ott. 2001, n. 3).
I mutamenti del quadro normativo generale hanno da ultimo prodotto l'esigenza di una codificazione ex novo in materia di beni culturali, portata a termine con l'emanazione nel 2004 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42), in cui sono state rielaborate le leggi organiche, tra cui anche la legge archivistica, che nel corso degli ultimi settant'anni avevano disciplinato i singoli settori dei beni culturali.
Con la nuova articolazione della struttura ministeriale disposta dal d.m. 27 nov. 2014 il numero delle Soprintendenze archivistiche è stato ridotto, attraverso una serie di accorpamenti operati su base territoriale. Il d.m. 23 gen. 2016 ha assegnato alle Soprintendenze, eccettuate quelle aventi sede in una Regione a statuto speciale, l'ulteriore competenza della tutela sui beni librari non statali.
La tutela degli archivi nella regione
Il territorio del Friuli Venezia Giulia è costituito da aree che tra età moderna e contemporanea hanno attraversato vicende istituzionali differenziate, talvolta in misura rilevante, tali da incidere sulla formazione e sui caratteri degli archivi della regione. Una parte dell’attuale territorio, grossolanamente corrispondente alle odierne province di Udine e di Pordenone, appartenne a lungo alla Repubblica di Venezia e, dopo la fine di questa, al Regno lombardo-veneto; la parte orientale, con Gorizia e Trieste, appartenne invece all’Impero e restò soggetta alla monarchia austriaca fino alla prima guerra mondiale. Mentre i territori occidentali della regione entrarono a far parte dello Stato italiano nel 1866, gli altri dovettero attendere fino al 1918. Basta questo a dar ragione, per esempio, delle strutture diverse che si riscontrano tra gli archivi storici dei comuni del Friuli Venezia Giulia.
Una cura costante per gli archivi è attestata, nelle diverse sedi locali, attraverso il tempo, ma l’interesse scientifico e un atteggiamento professionale nei loro confronti si manifestano a partire dal XVIII secolo. Gli archivi della regione beneficiarono dell’opera precorritrice di eruditi quali Carlo Morelli a Gorizia, Valentino Baldissera a Gemona, Michele della Torre a Cividale, Pietro Kandler a Trieste. La Provincia di Gorizia fu tra le prime grandi istituzioni amministrative a dotarsi formalmente, nel 1861, di un proprio Archivio storico.
Nell’ordinamento italiano postunitario l’organismo di tutela per gli archivi della regione aveva sede a Venezia: la Sovrintendenza agli archivi veneti. Tra i funzionari che la ressero va citato con speciale rilievo Bartolomeo Cecchetti; con la sua Statistica degli archivii della regione veneta (1880-1881) pubblicò un primo censimento archivistico della regione comprendendovi, oltre alle province già annesse al regno d’Italia, anche Gorizia e Trieste, ancora appartenenti all’Austria.
La Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia è entrata in attività nel novembre del 1963, in attuazione delle disposizioni del d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409; la sede veniva fissata a Trieste. La nuova soprintendenza subentrò, per il territorio regionale, nei compiti esercitati fino allora dalla Soprintendenza archivistica di Venezia. Primo soprintendente fu Ugo Tucci (1963-1974), seguito da Maria Laura Iona (1974-1995), Renata Da Nova (1995-2002), Pierpaolo Dorsi (2002-2017), Viviano Iazzetti (2018-2020). L'attuale soprintendente è Luca Caburlotto (dal 1 febbraio 2020).
Negli anni successivi al terremoto che colpì il Friuli nel 1976, la Soprintendenza fu particolarmente impegnata nell’opera di recupero degli archivi comunali ed ecclesiastici dell’area interessata dal sisma; successivamente fu condotto un lavoro sistematico di riordinamento, inventariazione e restauro dei fondi danneggiati.
Data di redazione: gennaio 2013
Data di ultimo aggiornamento: novembre 2020